Un team di ricercatori dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e delle Università di Catania e Ferrara ha rivisitato i dati dell’eruzione dell’Etna del 28 Dicembre 2014, aprendo la strada a nuovi modelli interpretativi dell’attività eruttiva sia del vulcano siciliano, sia dei vulcani basaltici in generale. Lo studio è stato pubblicato su Scientific Reports di Nature. Ce lo illustra, con un articolo di ampio respiro, Mario Mattia, primo tecnologo dell’INGV e componente del team.
di Mario Mattia

Il mondo scientifico, in generale, è estremamente conservatore.
E a ragione.
Quello che viene definito “conoscenza scientifica”, infatti, altro non è che una serie di ricerche che hanno superato il vaglio di tantissime conferme sperimentali e vengono accettate dalla maggioranza della comunità disciplinare di riferimento. E quando parlo di maggioranza voglio dire che comunque, in ogni comunità scientifica, esiste ed esisterà sempre una minoranza dissenziente. A volte questa minoranza ha interessi specifici e dunque non è serena nelle sue valutazioni (carriere, finanziamenti e rilievo sui media attirano tanto l’uomo comune quanto lo scienziato), altre volte in quelle minoranze si annida il seme che, una volta attraversati i complessi e lunghi percorsi di valutazione “tra pari”, sboccerà e produrrà o un avanzamento significativo o, più raramente, un radicale cambiamento di punto di vista.
Perché questa premessa vagamente filosofica anziché descrivere il contenuto della ricerca? E’ presto detto. La ricerca di cui voglio parlarvi, presentata su una importante rivista internazionale come Scientific Reports di Nature, fa parte, a nostro avviso, di quella minoranza di produzione scientifica che propone novità abbastanza lontane dagli standard di riferimento.
Presunzione? Può darsi.

Di certo ad unire il team dei ricercatori che hanno lavorato intorno a questa ricerca è stata una frase di Proust che, in un freddo giorno del febbraio 2015, il mio amico e collega Carmelo Ferlito pronunciò entrando nel mio ufficio di Piazza Roma 2 (dove ha sede l’INGV di Catania). Me lo ricordo posare il casco sulla mia scrivania, sorridere e dire «L’unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi». Gelato da questa frase, oltre che dal clima non mite di quei giorni, gli chiesi spiegazioni e lui cominciò a disegnare qualcosa su un foglio. Mi parlò di quello che aveva osservato prima e dopo l’insolita attività eruttiva etnea del 28 dicembre 2014, mi mostrò incredibili foto e filmati di fratture incandescenti che, nei giorni precedenti quell’eruzione, dissecavano il Cratere di Sud Est dell’Etna, e ancora immagini del gas che usciva copioso da quelle fratture, e infine le fenomenali dimensioni del “pezzo” di cratere che era venuto giù il 28 dicembre.
Le sue idee mi sembrarono, all’inizio, complicate e talmente fuori dagli schemi da suscitare un sano scetticismo. Ma dopo qualche riflessione e altre chiacchierate, decidemmo di coinvolgere altri colleghi, specialisti di geochimica dei gas e di deformazioni del suolo, con i quali condividere dubbi e voglia di capire. E così si venne a creare un gruppo abbastanza grosso all’interno del quale avviammo un dibattito intorno ad alcuni nodi centrali che riassumo di seguito: 1) come fanno, a volte, le fratture che tagliano le parti apicali dei crateri a mantenere, a pochi centimetri dalla superficie, temperature magmatiche (800-900 C°)?2) Che ruolo ha l’enorme quantità di gas che fuoriesce nelle parti apicali di alcuni dei crateri etnei? 3)Siamo sicuri che magma e gas siano legati da un rapporto molto stretto, come ci hanno insegnato all’Università e come scrivono nostri colleghi su tante riviste scientifiche (in sintesi, a tot quantità di magma equivale tot quantità di gas – termine generico che comprende molte specie gassose) tra l’altro facilmente calcolabile?
Come si vede tutto sommato sono delle domande banali. E, come spesso succede, le domande banali hanno risposte complicate da una serie di paradigmi di partenza che costringono noi ricercatori a complicate evoluzioni concettuali per far rientrare negli schemi del “conosciuto” ciò che invece può essere spiegato in modo semplice e intuitivo anche per non addetti ai lavori.
Fratture incandescenti? Calcoliamo quanto calore è in grado di generare il flusso di gas che passa dalla sommità dei crateri e vediamo se è in grado di portare la roccia a temperature magmatiche. Noi ci abbiamo provato e la risposta è stata sì.

L’Etna “tira fuori” ogni anno quantità enormi di gas. Dove finisce tutto il magma che dovrebbe averlo generato? Semplice. Da nessuna parte. Se si accetta l’idea che il legame non c’è. Il gas, dunque, “viaggia” indipendentemente dal magma ed è capace di attraversare, in una particolare condizione che viene chiamata di “fluido supercritico” tutta la massa magmatica che si trova nei condotti e nelle zone di accumulo sia superficiali che profonde.
Altra questione. Per spiegare le grandi deformazioni osservate in occasione dell’evento eruttivo del 28 dicembre 2014 molti colleghi avevano ipotizzato l’azione di un “dicco”, ovvero di una “lama” di lava che con forza si era intrusa nell’area del Cratere di Sud Est e aveva generato tutto quel popò di sconquasso che è stato osservato. Ma anche in questo caso c’era qualche problema. E’ un dato di fatto assodato, ad esempio, che un dicco, durante l’intrusione, genera un gran numero di terremoti proprio perché “spacca” letteralmente la roccia durante la sua risalita. Durante le eruzioni del luglio 2001, dell’ottobre 2002 e del maggio 2008 si verificò proprio questo: migliaia di micro terremoti e grandi deformazioni del suolo. E stavolta? Stavolta no. Solo pochi eventi sismici (circa una decina) e tra l’altro di difficile classificazione (non esattamente imputabili a puri processi di fratturazione). E le deformazioni? Piuttosto grandi nelle stazioni di misura vicine al Cratere di Sud Est, ma temporalmente coeve all’evento o immediatamente successive al suo inizio. E normalmente un dicco fa sentire la sua presenza anche in termini di deformazione del suolo prima della sua manifestazione “en plein air”. Inoltre, in questo strano episodio eruttivo la deformazione aveva un decadimento molto ravvicinato, ovvero le stazioni di monitoraggio più lontane non lo “vedevano” affatto. E i gas? Perché era aumentato il flusso di gas (in questo caso SO2) circa un paio di mesi prima dell’evento e perché questo flusso era drammaticamente diminuito nei giorni immediatamente precedenti l’episodio eruttivo?
Un bell’intrigo.
Nel frattempo, il gruppo di ricercatori iniziale si andò via via assottigliando. Molti ritennero che “i nuovi occhi” che la nostra ipotesi prevedeva fossero in realtà solo illusioni. E così ci ritrovammo, oltre il “visionario” Carmelo Ferlito, io, Valentina Bruno e Danila Scandura ad analizzare le deformazioni del suolo, Giuseppe Salerno e Tommaso Caltabiano in qualità di esperti di geochimica dei gas e il Prof. Massimo Coltorti, che dalla lontana Ferrara ci aiutava attraverso le sue idee e le analisi petrologiche svolte nel suo laboratorio.
Ci vedevamo in pittoresche riunioni che, dopo un paio d’ore di confronti, calcoli e schemi modellistici, si trasformavano inevitabilmente in gruppi di discussione filosofica (una volta abbiamo discusso sulla immagine di Dio nel medioevo, giuro..). E anche per questo, probabilmente, ci abbiamo messo un po’ di tempo a produrre il testo finale del lavoro che, da un paio di settimane, è stato accettato e pubblicato on line ed è liberamente reperibile a questo indirizzo (https://www.nature.com/articles/s41598-017-05318-9).
Ma rivediamo insieme le principali novità e perché questo nostro approccio è da considerarsi innovativo, rispetto al passato: 1) secondo il nostro modello il 28 dicembre 2014 si è verificato un episodio diverso dalle tante fontane di lava cui ci ha abituato l’Etna in questi ultimi anni. In particolare noi abbiamo ipotizzato che, a partire dal mese di ottobre 2014 l’incremento di SO2 ( e dunque di tutti i gas vulcanici, vapore acqueo in primis) ha prodotto un surriscaldamento della parte apicale del Cratere di Sud Est (o Nuovo Cratere di Sud Est, così battezzato avventurosamente da qualcuno, come se su un vulcano il termine “nuovo” avesse un significato) 2) Questo surriscaldamento è andato avanti fino al raggiungimento di una soglia critica, superata la quale sia la capacità di questa roccia ormai fusa di “immagazzinare” calore, sia l’effetto sigillante che questa massa aveva prodotto al normale flusso di gas, erano venute a mancare 3) a questo punto si innescò un fenomeno che è tipico dei vulcani di tipo “acido”, quelli tipici del Sudamerica, per intenderci (ma non solo) cioè il corpo magmatico viscoso che “tappa” il cratere si spacca e si verificano fenomeni come “nubi ardenti” e flussi piroclastici. 4) la massa che occupava la parte apicale del cratere, ormai rimossa e franata, induce una decompressione sul magma che risiede a livelli superficiali 5) questo magma risale velocemente, esercitando una violenta pressione sui fianchi del cratere che “simula” una intrusione, almeno dal punto di vista delle deformazioni del suolo. Ci sarebbe anche altro di cui parlare, come ad esempio l’inizio dell’attività alla Voragine subito dopo questo evento e che, secondo noi, è una ulteriore conferma del nostro modello, ma insistere sui particolari non aggiunge molto al modello che ho sopra descritto.
Non so se quello che ho descritto è chiaro in ogni sua parte. Quello che è sicuro è che, se avessi dovuto usare i paradigmi “mainstream” della comunità vulcanologica mi sarei dovuto arrampicare su specchi che prevedevano magma che risale lungo i condotti, degassa, raffredda e poi scende all’interno del vulcano per fermarsi chissà dove. E avrei dovuto parlare di un dicco “silente” che non produce sismicità significativa, né deformazioni che precedono l’inizio dell’evento. E avrei lasciato da parte anche il dato del crollo della quantità di gas che ha preceduto l’inizio dell’attività. Insomma, avrei dovuto usare gli occhi “vecchi”.
Correttezza impone di riportare che queste idee, come già detto, non necessariamente sono accettate e “giuste” solo perché pubblicate su una rivista internazionale importante. Una pubblicazione è solo una pubblicazione. La conoscenza scientifica è altra cosa.
Di certo non ci fermiamo qui. Già stiamo ragionando su un modello di più ampio respiro che, ancora una volta, sarà sottoposta al vaglio minuzioso dei nostri stessi colleghi di tutto il mondo. Se davvero rappresenterà una svolta lo vedremo solo tra diversi anni. Ed è giusto che sia così.
L’obiettivo cui stiamo puntando adesso è quello di provare a guardare i dati che emergono dalle fantastiche infrastrutture di monitoraggio di cui l’Etna è dotata, in modo diverso e, magari in futuro, riuscire a contribuire anche al miglioramento delle capacità di previsione delle varie attività eruttive ed alla mitigazione del loro impatto sulla popolazione.
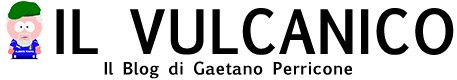
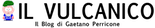







Commenti recenti