FONTE: INGVterremoti
Nel gennaio di quest’anno si è ricordato il cinquantesimo anniversario del catastrofico terremoto che ha devastato il Belice nel 1968 (magnitudo Mw 6.5 – Intensità epicentrale X scala MCS ). Per approfondire gli aspetti di questa sequenza sismica verranno pubblicati due articoli tratti dal volume “Il peso economico e sociale dei disastri sismici in Italia negli ultimi 150 anni”, di Emanuela Guidoboni, storica dei terremoti e dell’ambiente e fondatrice del Centro EEDIS (Eventi Estremi e Disastri), e Gianluca Valensise, geologo e sismologo dell’INGV. Il volume è stato edito da Bononia University Press (ISBN: 978-88-7395-683-9) e pubblicato nel 2011, in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. I dati su cui è basato il volume sono tratti dal Catalogo dei Forti Terremoti in Italia [1].
Anatomia di una catastrofe
Il terremoto colpì con numerose e violente scosse una vasta area della Sicilia occidentale compresa tra le province di Agrigento, Palermo e Trapani: un’area ritenuta non sismica dalle conoscenze scientifiche del tempo. Nel breve volgere di dieci giorni furono distrutte 9.000 case, numerose antiche chiese, vetusti palazzi e castelli. Si contarono alcune centinaia di vittime e oltre 100.000 senzatetto, 12.000 dei quali emigrarono quasi subito verso l’Italia del nord.
Contrasti istituzionali, una gestione delle risorse non controllata, denunce e conflitti resero difficile e lenta l’opera di ricostruzione. Errori, speculazioni, ma anche idee e preziosità si alternano in questa grande opera di recupero, non ancora conclusa dopo ormai cinquanta anni.
Gli effetti del terremoto
La sequenza sismica iniziò nel pomeriggio del 14 gennaio 1968 con una prima forte scossa alle ore 13:28 locali, che causò danni notevoli a Montevago, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale, nonché lesioni in alcuni edifici a Santa Margherita di Belice, Menfi, Roccamena e Camporeale. Meno di un’ora dopo, alle 14:15, nelle stesse località ci fu un’altra scossa molto forte, sentita anche a Palermo, Trapani e Sciacca. Due ore e mezza più tardi, alle 16:48, ci fu una terza scossa, che causò danni gravi a Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Margherita di Belice e Santa Ninfa. Lesioni di varia entità si aprirono in molti edifici di Alcamo, Calatafimi, Camporeale, Corleone e Roccamena; a Palermo ci furono danni in edifici di vecchia costruzione. A Gibellina e Salaparuta, in particolare, tutte le scosse precedenti quella più violenta – che accadde il giorno dopo – causarono serie lesioni e compromisero la stabilità degli edifici. Dopo queste prime scosse, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, all’epoca comandante dei Carabinieri di Palermo, visitando nel pomeriggio del 14 gennaio i centri più colpiti, raccomandò alla popolazione di pernottare all’aperto.
Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, alle ore 2:33 locali, una scossa molto violenta causò gravissimi danni e il crollo di alcuni edifici a Poggioreale, Gibellina, Salaparuta, Montevago e Santa Margherita di Belice; fu fortissima a Contessa Entellina e a Corleone, dove causò danni rilevanti, e fu sentita molto forte a Palermo, a Trapani e in tutta la Sicilia occidentale e centrale, compresa l’isola di Pantelleria.
La scossa più forte dell’intera sequenza avvenne poco dopo, alle ore 3:01, ed ebbe effetti disastrosi: crolli e distruzioni diffuse in un numero di località ben superiore a quello delle località già menzionate. Frequentissime e forti repliche non diedero tregua. I morti accertati ufficialmente furono complessivamente 231 e i feriti oltre 600. Fonti indipendenti ritennero, tuttavia, che il bilancio delle vittime fosse molto più alto: oltre 400 morti e più di 1.000 feriti[2]. Il numero relativamente contenuto delle vittime, se paragonato all’enorme portata delle distruzioni, fu dovuto principalmente all’allerta lanciato dal generale Dalla Chiesa.
Quasi tutta la zona collinare della Sicilia sud occidentale – circa 6.200 km2 – fu coinvolta nella disastrosa sequenza sismica del gennaio 1968. L’area dei massimi effetti fu localizzata nel medio e basso bacino del fiume Belice: includeva 12 comuni delle province di Trapani, Agrigento e Palermo, per una superficie di circa mille km2. Questo territorio non figurava allora tra quelli considerati a rischio sismico.
I paesi di Gibellina, Poggioreale e Salaparuta, in provincia di Trapani, e Montevago, in provincia di Agrigento, furono quasi totalmente rasi al suolo, con effetti valutati di grado X MCS. A Gibellina fu distrutto quasi il 100% delle unità immobiliari, pari a 1.980 edifici. Anche a Poggioreale e a Salaparuta fu distrutto il 100% del patrimonio immobiliare, rispettivamente formato da 993 edifici e a circa mille edifici. A Montevago fu distrutto il 99% delle unità immobiliari e fu danneggiato gravemente l’1% rimanente, su un totale di 1.393 edifici. In tutti questi paesi i pochi muri ancora rimasti in piedi crollarono completamente in seguito alla fortissima replica del 25 gennaio, alle ore 10:56 locali. Dopo questa nuova scossa rovinosa, che causò qualche altra vittima, fu proibito l’ingresso nei paesi di Gibellina, Montevago e Salaparuta.
Gravi distruzioni, con dissesti e crolli diffusi, colpirono i paesi e i territori comunali di Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa, Partanna e Salemi, a cui è stato assegnato il grado VIII-IX o IX MCS. Santa Margherita di Belice aveva 3.646 edifici: le scosse distrussero il 70-80% delle unità immobiliari e lesionarono leggermente le rimanenti. Gravi lesioni danneggiarono anche il palazzo Filangeri di Cutò e la chiesa madre. La replica del 25 gennaio fece crollare un’altra decina di case.
Santa Ninfa aveva 1.928 edifici: ne fu distrutto più del 43%; il 47% fu danneggiato gravemente e solo il 9% risultò lesionato in modo più leggero. La replica del 25 gennaio causò nuovi, gravi danni agli edifici. Partanna aveva 4.345 unità immobiliari: il 30% fu completamente distrutto, il 42% danneggiato gravemente, il 19% lesionato. La replica del 25 gennaio causò il crollo di numerosi edifici.
A Salemi, su 4.402 edifici il 24% fu distrutto, il 45% danneggiato gravemente e il 29% lesionato leggermente. La replica del 25 gennaio causò il crollo di una delle torri del castello di Federico II e danneggiò la chiesa madre, la Biblioteca Civica e il Museo del Risorgimento; crollò anche il ponte della strada per Agrigento. Nelle campagne di questi comuni andarono distrutte anche molte costruzioni rurali.
Oltre una decina di altre località subirono crolli totali più limitati, ma danni ingenti, gravi dissesti e crolli parziali estesi a parte del patrimonio edilizio (grado VIII MCS o appena inferiore).
Menfi aveva 5.978 edifici: la scossa fu rovinosa e danneggiò gravemente il 40-50% delle unità immobiliari, lesionandone lievemente una percentuale analoga. Gravi lesioni si aprirono nel castello medievale, in alcune chiese e nell’ospedale. La replica del 25 gennaio causò nuovi crolli. Nel comune di Vita, su un totale di 1.446 edifici, quelli distrutti furono il 10%, il 15% fu danneggiato gravemente e il 16% circa lesionato in modo leggero; si aprirono lesioni anche nei muri della chiesa madre, che crollò definitivamente con la replica del 25 gennaio.
Danni gravi ed estesi furono rilevati a Camporeale, Contessa Entellina e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo; a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento; ad Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo e frazione di Castello Inici, Castelvetrano e Gallitello Stazione, frazione del comune di Calatafimi.
Interruzioni delle linee ferroviarie furono rilevate tra Castelvetrano e Alcamo, e tra Castelvetrano e Salaparuta, dove al Km 29 crollò parzialmente una galleria.
In quasi cinquanta altre località, tra cui Mazara del Vallo, Corleone, Marsala, Sciacca e la stessa Palermo, le distruzioni e i crolli furono pochi, ma una parte consistente del patrimonio edilizio riportò comunque danni (effetti di grado VI-VII e VII MCS). In decine di altre località, incluse Agrigento e Trapani, ci furono danni leggeri.
La scossa principale del 15 gennaio 1968 fu avvertita in quasi tutta la Sicilia, fino a Catania, Messina e Milazzo; fu seguita da una lunga serie di repliche, alcune delle quali molto forti, che si protrassero sino al febbraio del 1969.
Perché tanti danni?
Le relazioni scientifiche e gli studi sugli effetti di questo terremoto, svolte da ingegneri, geologi e sismologi, concordarono nell’assegnare alle scadenti condizioni in cui si trovava gran parte del patrimonio edilizio un ruolo importante nella definizione qualitativa e quantitativa dei danni. Ancora una volta era sotto accusa l’edilizia tradizionale, priva di regole, realizzata male e ancor peggio mantenuta. La pessima esecuzione delle murature, tenute assieme con malte di scarsa qualità, l’assenza o l’insufficienza delle fondazioni e la presenza di tetti spingenti mal raccordati con le pareti esterne furono tutti fattori che contribuirono in larga misura a rendere catastrofici gli effetti delle scosse su edifici deboli e sostanzialmente fragili. A questi elementi macroscopici si aggiunsero i risultati delle prove di laboratorio relative al comportamento meccanico dei materiali da costruzione maggiormente impiegati nell’area danneggiata: i blocchi di tufo, tagliati con specifiche misure secondo l’uso della zona, e le malte dimostrarono, in generale, una scarsissima resistenza alle sollecitazioni sismiche.
Dalle indagini sul campo emerse che i pochi edifici correttamente costruiti con strutture di cemento armato avevano superato quasi indenni l’impatto delle scosse persino nell’area dei massimi effetti; infatti gli edifici ben costruiti furono esenti da danni, ma erano una minoranza. L’edilizia prevalente nei paesi distrutti era il risultato di un contesto economico povero, in cui l’agricoltura diffusa era condotta con metodi non intensivi e quasi arcaici, in piccoli appezzamenti familiari. L’economia monetaria era scarsa, i mercati scoraggiati da una pessima viabilità, e a fronte di tutto questo vi era un costo elevato dei materiali da costruzione di buona qualità, difficili da reperire sul posto.
In tutta l’area, che come si è detto all’epoca non era ritenuta a rischio sismico, non erano state adottate misure di sicurezza e di prevenzione, benché, come si ricorderà, la legge del 1935 richiedesse criteri edilizi “moderni” per tutti gli edifici costruiti sul territorio nazionale. Due anni dopo, nel 1970, l’avvio istituzionale delle amministrazioni regionali previste dalla Costituzione delegò alle singole regioni il controllo per l’applicazione delle norme di sicurezza.
Gli effetti sull’ambiente: frane, smottamenti e nuove sorgenti di acqua calda
A seguito del terremoto si attivarono frane e si aprirono spaccature nel terreno, spesso accompagnate da fuoriuscita di fango e, in taluni casi, da esalazioni gassose. Furono rilevate anche variazioni nel regime delle acque sotterranee. La maggioranza degli effetti fu osservata nelle zone di Gibellina, Montevago, Partanna, Camporeale, Contessa Entellina e Bisacquino. Le frane per crollo direttamente innescate dalle scosse furono di portata limitata e per lo più peggiorarono situazioni di instabilità preesistenti. Alcune frane interruppero le strade che portavano ad Agrigento e a Sciacca, rallentando l’arrivo degli aiuti.
Nei terreni circostanti le Terme di Segesta scaturirono nuove sorgenti di acqua calda, alcune delle quali furono temporanee e di breve durata; due sorgenti preesistenti aumentarono la loro portata.
La forte replica delle ore 17:43 del 16 gennaio fu avvertita anche in mare da un peschereccio di Sciacca, in navigazione nel Canale di Sicilia a una decina di chilometri dalla costa. I pescatori dichiararono che nell’istante della scossa un movimento vorticoso delle acque del mare aveva reso loro impossibile governare la barca.
L’impatto disastroso
Il terremoto interessò complessivamente un’area di circa 5.500 km2, popolata da oltre 1.300.000 persone, comprendente anche le aree urbane di Palermo, Trapani, Mazara del Vallo e Marsala. L’area più colpita era nell’entroterra collinare della Sicilia sud-occidentale, che all’epoca presentava, in parte, i caratteri tipici di una regione marginale nell’economia e nella vita sociale sia regionali sia nazionali. La base produttiva di quest’area, essenzialmente agricola (più della metà della popolazione attiva era impiegata nell’agricoltura), comprendeva zone caratterizzate da sistemi di conduzione e assetti quasi arcaici e zone dove prevaleva la viticoltura specializzata. Quest’ultime erano collegate ad alcune infrastrutture agro-industriali. Notevoli furono i danni nel settore viticolo, che rappresentava un elemento trainante dello sviluppo economico della regione e una notevole fonte di reddito.
I contadini erano per lo più residenti nei vecchi paesi collinari e non abitavano che in minima parte sui fondi agricoli. Oltre alle abitazioni e agli edifici rurali di servizio, il terremoto distrusse anche molte infrastrutture e uccise numerosi capi di bestiame. Le stime dei danni elaborate dal governo, rese note prima della rovinosa replica del 25 gennaio, indicarono in 200 miliardi di lire le spese necessarie per riparare i danni. La stessa fonte governativa stimò in 5.200 gli alloggi completamente distrutti nella sola provincia di Trapani; questa cifra saliva a circa 9.000 per tutta l’area danneggiata. Complessivamente la popolazione rimasta senzatetto fu di circa 100.000 unità, delle quali 20.000 nella sola provincia di Agrigento.
Gibellina prima del terremoto: veduta del paese in una foto del 1965 scattata dalla stazione ferroviaria.
Il terremoto causò gravi danni anche alle attività commerciali: circa 500 commercianti residenti nell’area danneggiata ebbero gli esercizi distrutti e 3.000 aziende commerciali siciliane videro diminuire notevolmente il loro giro d’affari. L’attività commerciale e industriale fu particolarmente colpita nell’agrigentino, area che non si era ancora ripresa dai disastrosi eventi franosi che avevano colpito il capoluogo il 19 luglio 1966.
Dalla grande paura a un’emergenza disordinata
Al sopraggiungere delle due violente scosse della notte del 15 gennaio la popolazione di una vasta area della Sicilia occidentale abbandonò le abitazioni rifugiandosi nei luoghi aperti e pernottando all’addiaccio o nelle automobili. Nei maggiori centri urbani, soprattutto a Palermo e a Trapani, ci furono scene di panico ed ingorghi stradali. Migliaia di persone, nelle più popolose città, abbandonarono le case ed i loro posti di lavoro causando la paralisi dei servizi e delle attività economiche. La scossa del 15 gennaio e la forte replica del 25 causarono molto panico anche ad Agrigento, dove la popolazione abbandonò le abitazioni per trascorrere diverse notti all’aperto nella Valle dei Templi.
Le condizioni delle popolazioni colpite si presentarono subito estremamente precarie e furono aggravate anche dalla lentezza e della disorganizzazione dei primi soccorsi. La scossa principale aveva gravemente danneggiato, fra l’altro, anche la rete di erogazione elettrica. In alcuni centri gravemente colpiti, secondo la stampa siciliana, per tutta la giornata seguente alla scossa principale la popolazione non ricevette alcun soccorso organizzato; molte persone, fuggite dai paesi, vagarono per ore nelle campagne circostanti. Per parecchi giorni molte famiglie rifugiatesi in piena campagna, nei pressi delle case coloniche e lontano dalle tendopoli, non ricevettero che aiuti sporadici.
Nelle tendopoli le condizioni igienico-sanitarie si fecero molto serie e i problemi di sovraffollamento nelle tende, abitate in media da 28-30 persone a fronte di una capienza prevista di 10 unità, erano gravi. Molte furono le morti causate dall’insorgere di malattie polmonari; gli sfollati dai centri danneggiati preferivano alloggiare in condizioni di sovraffollamento piuttosto che separare il nucleo familiare o abbandonare i propri averi trasferendosi negli alloggi requisiti in località distanti.
A Palermo il panico generato dal terremoto fu enorme; nella serata del giorno 15 si svolsero processioni nelle strade dei rioni maggiormente danneggiati; riti religiosi furono indetti anche in altre località della Sicilia occidentale nei giorni successivi all’evento principale. Il succedersi delle scosse alimentò una costante paura di vivere in edifici in muratura lesionati.
La scarsa organizzazione dei soccorsi e il proliferare di interventi di beneficenza non coordinati costituirono un altro fattore di limitazione dei trasferimenti dalle tendopoli ed alimentarono episodi di accaparramento, spesso ad opera di individui provenienti da località non danneggiate. Non mancarono episodi di speculazione e strozzinaggio sugli averi delle popolazioni scampate che, viste le impellenti necessità, erano costrette a vendere sottocosto bestiame e beni vari, spesso per procurarsi il denaro necessario per abbandonare definitivamente il luogo d’origine.
A due settimane dal terremoto del 15 gennaio, secondo le dichiarazioni dei sindaci dei paesi sinistrati, mancavano viveri, tende, medicinali, e le baracche che erano già state costruite erano insufficienti. Pane e acqua scarseggiarono fin dai primi giorni nelle tendopoli e in alcune località solo parzialmente danneggiate. Oltre ai medicinali mancavano le attrezzature, il sangue e persino le maschere per proteggere i soccorritori dalle esalazioni dei cadaveri e delle carogne di animali in via di decomposizione.
Le prime autocolonne di soccorsi partite da Agrigento e da Sciacca furono ostacolate dalle interruzioni di alcune strade causate da frane e crolli di ponti in seguito alle scosse. Tra le località maggiormente danneggiate furono predisposti dei ponti aerei con l’ausilio degli elicotteri dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Per ordine del Ministro dell’Interno, il Prefetto di Agrigento decretò la requisizione di tutti gli automezzi e autotrasporti disponibili.
Da più di venti anni la Sicilia godeva di una speciale autonomia politico-amministrativa nei confronti del governo nazionale italiano. Tuttavia, in alcuni settori d’intervento le decisioni del governo centrale furono prevalenti. Furono, infatti, gli uffici del Genio Civile e il Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia, con sede a Palermo, posto alle dirette dipendenze del Ministero dei Lavori Pubblici, ad espletare gran parte delle operazioni di verifica dei danni e di programmazione degli interventi di ricostruzione.
Dai soccorsi alla ricostruzione
Nei giorni immediatamente successivi al terremoto tutti gli organi di stampa posero unanimemente l’accento sulla mancanza di qualsiasi piano d’intervento. Alcuni opinionisti evidenziarono le ricorrenti sovrapposizioni di competenze e i conflitti, o le competizioni incomprensibili tra le autorità civili e quelle militari, o tra esponenti del governo regionale e funzionari del governo nazionale, nell’organizzare l’opera di soccorso. Le disfunzioni ebbero conseguenze gravi: quantità enormi di generi alimentari ed attrezzature di soccorso furono concentrate dove non vi erano particolari bisogni, mentre dalle località più colpite si levavano drammatiche richieste di invio di soccorsi e materiali. Le disfunzioni e i ritardi ebbero tuttavia il merito di offrire lo spunto per avviare sulla stampa nazionale un vasto dibattito sulla legge di riordino del settore della protezione civile, la cui discussione era bloccata in Parlamento per contrasti fra diversi gruppi politici.
A dieci giorni dalla violenta scossa del 15 gennaio erano state impiantate 11 tendopoli, che accoglievano più di 16.000 persone: circa 9.500 in provincia di Trapani, 4.000 nella provincia di Agrigento e 2.600 in quella di Palermo. Gli sfollati ricoverati nei centri di raccolta (scuole, alberghi, edifici pubblici e case private) erano, alla stessa data, 10.650 in provincia di Trapani e 3.050 in quella di Palermo, per un totale di quasi 14.000 persone. Molti posti letto in edifici in muratura, messi a disposizione delle autorità, non potevano essere utilizzati perché mancavano i materassi.
Testimonianze di alcuni abitanti di Santa Ninfa, riportate dalla stampa nazionale, e in particolare le dichiarazioni rilasciate da don Antonio Riboldi, all’epoca parroco del paese e in seguito coraggioso accusatore di interessi illegali sulla ricostruzione, resero pubblico il fatto che i primi soccorsi erano giunti da militari statunitensi nel pomeriggio del lunedì 15 gennaio. Solo dopo cinque giorni dalla scossa principale, ossia il 20 gennaio, erano giunti i primi soccorsi organizzati, portati dalla Marina Militare italiana, che aveva ricevuto disposizioni in tal senso solo il giorno precedente.
La situazione di disorganizzazione causò proteste sia in Sicilia sia a Roma, e vari episodi di intolleranza. A Palermo le scosse del 15 e del 25 gennaio resero drammatico il problema delle abitazioni per gli sfollati dai fatiscenti quartieri del centro storico, che avevano largamente risentito degli effetti sismici.
Le comunicazioni ufficiali del governo (terzo mandato di Aldo Moro) durante la seduta parlamentare del 22 gennaio 1968 attribuirono le difficoltà incontrate nel portare soccorsi alle popolazioni ad avversità climatiche, all’interruzione delle strade o alla loro mancanza, e all’atteggiamento non collaborativo delle popolazioni. Da più parti fu denunciato l’uso strumentale del terremoto sia da parte delle forze politiche di opposizione, sia da parte di quelle di governo. Lo scontro politico ebbe conseguenze negative sull’opera complessiva di soccorso e di ricostruzione. In realtà la quantità di aiuti e di concessioni elargite dallo Stato era stata notevole, ma era mancato quasi completamente una piano per una loro razionale ed efficace ripartizione. A tutto ciò si aggiunse una strisciante polemica sulla reale entità dei danni causati dal terremoto tra i rappresentanti del governo regionale siciliano e quelli del governo nazionale.

Santa Ninfa: i resti della chiesa Madre.
Verso la fine di gennaio 1968 i medici presenti nella zona terremotata dichiararono a più riprese sulla stampa nazionale che le tendopoli dovevano essere al più presto smontate, per evitare che le precarie condizioni igieniche, unite all’inclemenza della stagione invernale, causassero l’insorgere di epidemie e la morte degli individui più deboli. Se ai dati relativi alla popolazione nelle tendopoli e nei centri di raccolta si aggiunge il numero di coloro che se ne erano andati – circa 10.000 persone – si ha un totale di circa 40.000 individui che avevano perso la residenza, su di un totale di 80.000 residenti nelle aree maggiormente danneggiate.
A Vita, il giorno immediatamente successivo alla scossa principale, gli abitanti si erano accampati in luoghi aperti, costruendo da soli capanne di frasche e di canne con tetti di paglia. Il 22 gennaio si era diffusa la notizia che il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche della Sicilia, su disposizione del Ministro dei Lavori Pubblici, aveva ordinato 5.235 baracche, la cui fornitura era prevista nell’arco di 20-40 giorni. Il 2 marzo seguente le baracche impiantate, secondo i dati pubblicati, erano solo 92.

Poggioreale: i resti della chiesa oggi, nel sito abbandonato.
Le autorità facilitarono in ogni modo il movimento migratorio, concedendo biglietti ferroviari gratuiti e rilasciando, senza formalità o intralci burocratici, i passaporti. Con questa linea di condotta si accolsero le richieste dalla gente, ma soprattutto si percorreva la strada più semplice per attenuare la pressione sociale nei paesi devastati. Contro questa strategia dell’abbandono si pronunciarono le organizzazioni locali degli agricoltori e le associazioni sindacali. Dopo la rovinosa replica del 25 gennaio 1968 le autorità proclamarono i paesi di Gibellina, Montevago e Salaparuta “zone proibite all’ingresso”.
Le perizie dell’ufficio tecnico del Genio Civile di Agrigento negli ultimi giorni del gennaio 1968 riportarono le cifre dei senzatetto per nuclei familiari: 750 famiglie a Montevago, 2.100 a Santa Margherita di Belice, 200 a Sciacca, per un totale di circa 80.000 persone. A circa un mese di distanza dall’inizio del terremoto, attorno alla metà del febbraio 1968, nella sola provincia di Trapani circa 9.000 senzatetto erano ricoverati in edifici pubblici, 6.000 in tendopoli, 3.200 in tende sparse e 5.000 in carri ferroviari, mentre 10.000 persone erano emigrate in altre province. Rimanevano da sistemare circa 47.000 persone.

I superstiti in cammino verso i campi di accoglienza.
Una folla di terremotati prende la via del nord
L’impatto degli eventi sismici sulla dinamica demografica complessiva delle zone colpite si evidenziò attraverso una brusca accelerazione del già consistente fenomeno migratorio, soprattutto della popolazione maschile in età lavorativa, verso il nord d’Italia e i paesi dell’Europa settentrionale. Solo i provvedimenti restrittivi dell’immigrazione adottati dalla Svizzera negli ultimi giorni di gennaio, la progressiva saturazione delle aree di accoglienza nel nord d’Italia, la rassegnazione e la volontà di ricostruire rallentarono momentaneamente il flusso migratorio, che era cresciuto notevolmente dopo la replica del 25 gennaio 1968.
Il 29 gennaio, secondo le dichiarazioni rilasciate alla stampa dai sindaci dei comuni maggiormente danneggiati, erano quasi 10.000 le persone che avevano lasciato i luoghi di residenza o avevano fatto richiesta in tal senso. Complessivamente si valutò in circa 12.000 il numero delle persone che lasciarono le zone terremotate partendo dalla stazione ferroviaria di Palermo. A Milano il 28 gennaio si stimava intorno a 1.300 il numero dei profughi giunti dalle località siciliane danneggiate dal terremoto, di cui 900 circa furono posti completamente a carico dell’assistenza pubblica.
A Santa Margherita di Belice gli emigrati furono un migliaio, e a fine gennaio nelle tendopoli allestite nei pressi dell’abitato distrutto erano rimaste 3.000 persone, rispetto ai 7.841 abitanti costituenti la popolazione presente prima del terremoto.
A Camporeale, in seguito al disastro, abbandonarono il paese in direzione di altre località siciliane o dell’Italia settentrionale ben 2.600 abitanti su 6.093. Solo 350 persone, alla fine del gennaio 1968, erano rimaste nelle tendopoli e in ripari di fortuna nella zona di Montevago.
Nei 14 comuni dell’area maggiormente danneggiata la popolazione presente scese dalle 96.417 unità del censimento 1961 alle 85.415 rilevate nel 1971. A circa un mese dal terremoto circa 10.000 persone residenti nella provincia di Trapani si erano trasferite in altre province. Tra le conseguenze a medio termine si accentuò la tendenza all’accentramento della popolazione nelle città e lo spopolamento nelle campagne. Iniziò l’afflusso di manodopera nordafricana impiegata nei lavori agricoli stagionali, che colmò i vuoti causati dall’emigrazione nelle schiere del bracciantato agricolo [2].

Una delle tendopoli approntate ai bordi delle strade.
Interventi statali ingenti, mal distribuiti e corrosi da interessi illegali
I primi provvedimenti del governo nazionale furono adottati nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri svoltasi il 20 gennaio 1968. Tra le misure d’emergenza adottate figurarono: la sospensione del pagamento delle imposte nelle zone danneggiate fino al 31 dicembre 1968; una moratoria sui debiti e le cambiali; la sospensione del pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e rurali; l’elargizione di un contributo di 500.000 lire una tantum a beneficio dei capifamiglia, previa presentazione di un certificato rilasciato dalla Prefettura o dal Genio Civile, che attestasse la perdita di ogni avere; l’aumento dei sussidi di disoccupazione e l’avvio di una politica di investimenti in opere pubbliche per assorbire la disoccupazione.
Contributi ed esenzioni dalle imposte furono adottati per i lavoratori autonomi; fu decisa l’erogazione di un finanziamento a fondo perduto dell’importo massimo di 500.000 lire per le riparazioni urgenti dei fabbricati rurali. Si stanziarono 6 miliardi per l’acquisto di baracche e 15 miliardi per la costruzione di case di edilizia economico-popolare nelle province di Trapani, di Palermo e di Agrigento. Complessivamente l’impegno finanziario previsto ammontava a 45 miliardi e 360 milioni [3]. Contemporaneamente anche l’Assemblea Regionale Siciliana approvò una legge di intervento nelle aree danneggiate.

Santa Ninfa: baraccopoli costruita in contrada Acquanova.
Una ricostruzione importante, benché offuscata e non conclusa
Le competenze in materia di indennità di esproprio delle aree e di costruzione degli alloggi furono assegnate al Provveditorato alle Opere Pubbliche di Palermo, controllato dal ministero dei Lavori Pubblici. Per programmare la propria azione questo ente adottò gli indici di danno calcolati per ciascuna località dal Genio Civile nei giorni immediatamente successivi alla scossa del 15 gennaio. Tali indicatori non tenevano però conto dei danni, anche molto gravi, causati dalle forti repliche successive, e furono quindi giudicati ampiamente sottostimati.
I decreti legge e la legge-quadro per la ricostruzione (n. 241 del 18 marzo 1968) indicarono le località di Montevago, Gibellina, Poggioreale e di Salaparuta come centri da trasferire completamente; furono, invece, classificati come paesi soggetti a parziale trasferimento dell’abitato Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa, Sambuca di Sicilia, Calatafimi, Salemi, Vita, Camporeale e Contessa Entellina [2].
Ostacoli di natura sociale e politica si incontrarono anche nella scelta dei terreni su cui edificare i nuovi centri abitati. La nuova Gibellina fu localizzata in prossimità della stazione ferroviaria di Salemi e dello svincolo autostradale, nella convinzione che ciò facilitasse il decollo industriale dell’area e il risveglio della vita economica, ancora fortemente legata ad attività agricole. La scelta delle nuove localizzazioni per i centri di Salaparuta e Poggioreale fu dettata da motivi connessi alla disponibilità di terreni pianeggianti o in lieve pendenza, che permettessero l’ulteriore espansione dei paesi, evitando i rischi di instabilità a causa di pendenze accentuate.
Non sempre però le scelte operate si dimostrarono valide e svariati fattori contribuirono ad accentuare le difficoltà della ricostruzione. Molti furono gli operatori, pubblici e privati, ai quali furono affidate competenze, causando sovrapposizioni e conflitti che ebbero l’effetto negativo di rallentare le operazioni svalutando, di fatto, l’entità dei finanziamenti concessi della Stato. La precaria situazione economica delle zone danneggiate, venendo a mancare l’effetto volano dei capitali locali e dei consumi, non favorì il formarsi di un nuovo tessuto socio-economico integrato.
La mancanza in loco di materiali da costruzione fondamentali, quali ferro e cemento, ritardò ulteriormente l’opera di ricostruzione. Sul finire del 1973, solo il 10% degli alloggi necessari era stato edificato; per di più, questi alloggi non potevano essere assegnati in quanto non erano state ultimate le necessarie opere di urbanizzazione primaria (strade, acquedotti, reti elettriche) ed erano completamente assenti i servizi amministrativi e commerciali. Secondo i dati del censimento del 1971, nell’area maggiormente danneggiata le abitazioni precarie ammontavano a 15.056; nel 1973, a cinque anni dal terremoto, i baraccati erano ancora 48.182. La realizzazione delle nuove infrastrutture procedeva a rilento.
Manifestazioni di protesta e interpellanze parlamentari si succedettero a partire dal 1970. Nel 1976, secondo i dati riportati da un’inchiesta conoscitiva promossa dalla Commissione Lavori Pubblici della Camera dei Deputati (quinto governo Moro/quinto governo Andreotti), oltre 47.000 cittadini delle zone terremotate risiedevano ancora nelle baraccopoli. Solo 225 abitazioni erano state assegnate e molte delle infrastrutture, le opere sulle quali si erano concentrati gli interventi, giacevano inutilizzate; il loro destino di “cattedrali nel deserto” era irrimediabilmente segnato. Un coacervo di fattori fece di fatto fallire l’“utopia urbanistica” dei progettisti della ricostruzione.
Nonostante le tante difficoltà, ma grazie alla volontà e alla forza di resistenza dei sindaci e dei residenti rimasti, alla fine i paesi furono ricostruiti. I modelli adottati nelle ricostruzioni furono diversi e spesso opposti. In alcuni casi si tese a riprendere e a conservare l’antico volto storico dell’abitato, integrando anche parti delle rovine nello scenario urbano (Santa Margherita Belice); in altri prevalsero idee di modernizzazione, con l’adozione di forme urbanistiche lontane e non storiche (la città giardino, la città comunitaria), fuori contesto, ma non prive di una certa idealità, che oggi però appare muta e svuotata da quella complessa temperie.
Nel Belice hanno operato architetti, urbanisti e artisti, che hanno portato all’opera di ricostruzione un contributo importante. Il Belice divenne anche il luogo di un pensiero sociologico critico e vigile, contro collusioni fra istituzioni e interessi malavitosi. Protagonisti di primo piano furono Danilo Dolci (1924–1997), poeta ed educatore, teorico della non-violenza (definito il Gandhi italiano), e don Antonio Riboldi (1923-2017), allora parroco di Santa Ninfa, autorevole e coraggioso testimone della vita pubblica italiana (fino a tempi recentissimi) per la sue aperte e reiterate denunce contro interessi illegali politico-mafiosi. In quegli anni della ricostruzione don Riboldi aveva trovato l’appoggio del deputato siciliano Piersanti Mattarella, divenuto nel 1978 presidente della Regione Siciliana, e del generale Carlo Alberto della Chiesa, entrambi poi assassinati da Cosa Nostra, rispettivamente il 6 gennaio 1980 e il 3 settembre 1982.
La legislazione adottata nei decenni consentì un miglioramento delle condizioni generali dell’attività vitivinicola, ma non riuscì nel breve e medio termine a fare evolvere con decisione lo stato di arretratezza e la frammentazione delle aziende agricole operanti nelle aree più lontane dalla costa. Fu vicino al mare che decollò poi, dopo alcuni decenni, un’economia turistica, ancora in via di consolidamento. Nelle regioni collinari interne l’impatto del terremoto sulla vita e sulle attività degli abitanti fu paragonabile a una drammatica cesura, che interruppe modi consolidati di abitare e di coltivare la terra.
L’arte salva la memoria
I vecchi paesi distrutti della valle del Belice sono in gran parte ancora visibili, come cicatrici su quel bellissimo e fertile territorio. Rappresentano oggi quel paesaggio delle rovine che segna spesso il centro e il sud dell’Italia e di altri paesi del Mediterraneo. Qui le rovine sono presenti da tempo immemorabile, testimonianze di civiltà scomparse o di paesi abbandonati anche di recente. Gli abitanti le tollerano da sempre e ci convivono. Le rovine diventano un veicolo di memoria, un segno di radici, che il disuso dei luoghi non sempre cancella.

Gibellina: veduta del grande cretto di Alberto Burri, la prima rovina sismica divenuta un monumento alla memoria.
In alcuni paesi ricostruiti del Belice, in quelli che hanno vicinanza stretta con i vecchi siti abbandonati, sono stati allestiti in anni recenti dei percorsi pedonali definiti “della memoria”, portandovi illuminazione pubblica e panchine, come se fossero un parco dei ricordi o dei ponti verso il passato. In questi luoghi, che solo il nostro profondo sud sa concepire, si comunica con la storia del posto, con i resti di vecchie case squarciate, con un passato che la cultura diffusa del Paese stenta a ricordare. In queste strani percorsi si distinguono qua e là fra le macerie eleganti portoncini, fini modanature architettoniche, assieme a poveri muri semicrollati fatti di ciottoli, che lasciano intravvedere misere stanzette. Le tracce di grandi fatiche della sopravvivenza e di piccoli o grandi privilegi o soprusi sociali emergono nello stesso modo dal loro azzeramento. La percezione di questi luoghi non è lontana da quella di un’opera d’arte.
Verso le colline della vecchia Gibellina distrutta e abbandonata, sotto il sole o nelle notti di luna, si vede biancheggiare in lontananza una sorta di fantasma: è il grande cretto di Alberto Burri, un’enorme colata di cemento bianco che compatta dodici ettari di macerie del centro storico di Gibellina. Il progetto fu avviato nel 1984 e terminato nel 1989. Le macerie furono raccolte con i bulldozer, compattate e tenute insieme da reti metalliche. Sopra questi blocchi omogenei, alti circa un metro e 60, si colò il cemento bianco. Il tracciato dei blocchi e delle fenditure ricalca l’impianto urbanistico di Gibellina. Qui l’arte salva la memoria. Una parte delle rovine, fatte di antichi vicoletti e contorti percorsi medievali, sono stati monumentalizzati e resi iconici dal cemento bianco. E’ il primo monumento alle rovine di un terremoto di tutta l’area mediterranea. Ha la forza e la semplicità di un segno alla coscienza del Paese.
a cura di E. Guidoboni (Centro EEDIS) e G. Valensise, INGV-Roma1.
https://ingvterremoti.wordpress.com/
Con il titolo: una delle foto della mostra sul terremoto del Belice, in corso presso la Biblioteca regionale Centrale di Palermo
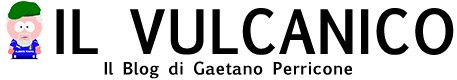
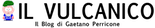












Commenti recenti