
Mario Mattia è primo tecnologo presso l’Osservatorio Etneo INGV. Da molti anni si occupa della tettonica della Sicilia sudoccidentale e in particolare della “caccia” alle faglie che hanno causato sia il terremoto del gennaio 1968, che quelli (almeno due) che hanno distrutto l’antica città di Selinunte. Coordina un progetto di ricerca finanziato dalla Struttura “Terremoti” dell’INGV di cui fanno parte ricercatori dell’Università di Catania, Napoli, Palermo e Sassari, oltre che dell’INGV di Catania, Palermo e Roma. Proprio in questi giorni i risultati del lavoro di questi anni sono stati presentati alla gente del Belice. Inevitabilmente, però, non è rimasto indifferente ai temi politici che hanno fatto sì che il terremoto del Belice venga oggi ricordato come una catastrofe da tutti i punti di vista.
di Mario Mattia
L’ingenua speranza di tenere lontano il terremoto da parte della gente del Belice è testimoniato dall’episodio che ci racconta Lorenzo Barbera in un suo bellissimo libro intitolato “I ministri dal cielo”, dove parla di un padre che, al verificarsi della prima scossa accaduta all’ora di pranzo del 14 gennaio 1968, va a riprendere suo figlio che giocava ad acchiappareddu nella piazza di Vita (TP) per portarlo dentro casa. ”Dentro, dentro, disgraziato! Dentro che c’è lu terremoto”, dice l’uomo al ragazzino. E letteralmente chiuse fuori dalla sua vita, dalla sua famiglia, dal suo mondo “lu terremotu”.
Una immagine che mi ha sempre colpito per la sua icastica efficacia. Sbattere fuori il terremoto. Per non subirne le conseguenze.

Ma purtroppo non andò così e quella stessa notte, alle 3 del mattino, una scossa di magnitudo intorno a 6 distrusse interi paesi della Valle del Belice, uccise 352 persone, ne ferì 576 e lasciò senza casa circa 55.000 tra uomini, donne, vecchi e bambini. E, tutto sommato, quella forte scossa del mattino prima fu una benedizione perché fece sì che molti si salvarono proprio perché dormirono nelle macchine e nelle campagne per la paura di un nuovo terremoto. Altri, anche per colpa del tremendo freddo che quell’anno colpì la valle portando per la prima volta dopo moltissimi anni la neve, invece non scamparono la morte. Sepolti sotto case troppo deboli anche per sopportare un terremoto di energia non grandissima.
Fu il primo terremoto devastante del dopoguerra. Nessuno sapeva cosa fare. La Protezione Civile non esisteva. “L’Italia è una Repubblica fondata sul precedente, non sul lavoro – disse in una celebre intervista Giulio Andreotti – e quando si verificò il terremoto del Belice non c’era nessun precedente. E c’era anche la paura di crearlo, un precedente.”
Il terremoto di Messina e quello di Avezzano erano troppo distanti nel tempo. Nessuno dei governanti della neo-potenza economica italiana aveva mai affrontato una simile emergenza. E dunque una litania di ritardi, di risposte approssimative ed inefficaci e di ignobili scaricabarile, ci restituiscono l’immagine di quello che è e resterà nella storia italiana come il “precedente” cui tutti, ancora oggi, guardano con terrore.
“Non deve finire come nel Belice”, è una frase che abbiamo sentito dire tante volte da ministri e politici di tutta Italia quando, purtroppo, in seguito si sarebbero verificati altri terremoti distruttivi. “Mai più un altro Belice” si disse per il Friuli, per l’Irpinia e via di tragedia in tragedia. Fino ai giorni di Amatrice.
Due giorni senza soccorsi. Tende senza brande. Convivenze forzate anche di 20 persone per tenda. Per mesi. Senza intimità. Senza potere preparare un pasto caldo, ma obbligati a far uso della mensa militare. Col divieto di assembramento. E poi le baracche. Per un tempo infinito. Le ultime sono state smantellate negli anni ’80. Ma c’erano i biglietti ferroviari di sola andata disponibili gratis. E i passaporti subito pronti per qualunque destinazione.
Questa la risposta dello Stato ai “sudditi” siciliani. Quarantamila emigrati in tutto il mondo. Comunità disgregate per sempre. Promesse di sviluppo tradite e soldi che risultano solo nelle contabilità dello Stato, ma che in realtà mai arrivarono alle comunità. Si potrebbe continuare per ore a scrivere degli errori, delle differenze con la gestione, ad esempio, dell’emergenza Friuli, costata molti più soldi allo Stato ed elogiata come virtuosa. Ma oggi, a quasi cinquant’anni da quell’evento, non ha più senso interrogarsi, capire. Razionalizzare.
Ciò che resta sono le fotografie in bianco e nero di un pezzo di Italia che è diventata archetipo di tutti gli approcci approssimativi e sconclusionati (quando non criminali) che hanno caratterizzato la storia recente di questo paese. E quelle foto parlano. Ci raccontano di “quelli lì” come li chiamò Sciascia in un celebre articolo che rende in modo perfetto quella che era la visione della Sicilia da parte dei nostri compatrioti (?).


«….quello che invece scatta con puntuale efficienza è il triste rituale demagogico e il richiamo alla unità e solidarietà sentimentale di un paese effettualmente disunito, pieno di contrasti e di contraddizioni, a livelli diversi e di fatto inunificabili. E di fronte alle immagini di Gibellina distrutta ci pareva di sentire i commenti di certa gente al cui cuore fanno appello certi giornali del nord (notoriamente antimeridionalisti) quando aprono sottoscrizioni: “vivono in case fatte di pietro e gesso, quelli lì”; “mica conoscono il cemento armato, quelli lì” ;e così via. La stessa voce, lo stesso accento, da cui abbiamo sentito che in Sardegna ci vorrebbero le bombe che gli americani impiegano contro i vietcong e che in Sicilia, salve (non si sa come) le brave persone che forse ci saranno, ci vorrebbe addirittura l’atomica; quella stessa voce da cui qualche volta ci tocca ricevere il complimento che non sembriamo siciliani. ”Quelli lì”: lì a Santa Margherita, a Montevago, a Gibellina, a Salemi; quelli che vivono nelle case di gesso e ci muoiono; quelli cui soltanto restano gli occhi per piangere la diaspora dei figli; pulviscolo umano disperso al vento dell’emigrazione e che lo Stato soltanto pesa nella bilancia dei pagamenti internazionali; quelli che ancora faticano con l’aratro a chiodo e col mulo; quelli che non hanno né scuole né ospedali, né ospizi, né strade….».
Parole durissime che avrebbero dovuto urtare le coscienze dei siciliani e invece non sortirono nessun effetto. E dopo poco tempo gli stessi siciliani preferirono non vedere lo scempio della ricostruzione, degli interessi mafiosi e della promessa di sviluppo tradita. E, come il resto degli italiani, sbuffavano di noia se al telegiornale passavano le notizie delle proteste dei belicini contro i ritardi, i soldi che mancavano, le leggi che si affastellavano governo dopo governo creando grovigli inestricabili.
“I soliti siciliani che aspettano che il pero gli caschi in bocca”. Può esistere un lieto fine in questa storia, oggi che quei bambini scalzi nel fango delle tendopoli sono adulti e che quei vecchi che ci guardano da quelle vecchie foto con le loro coperte sulla testa non ci sono più da tempo? Non lo so. Io appartengo alla Sicilia “sperta” che è cresciuta sotto l’Etna e non ho titoli per dirlo. Al massimo, posso percorrere le strade tra Castelvetrano e Partanna e perdermi tra campi di grano e infinite vigne allineate e perfette, coltivate con metodi all’avanguardia. E magari fermarmi a bere un bicchiere di rosso dal sapore forte e deciso. Come i volti degli uomini che sorridono e alzano le spalle se gli chiedo di raccontarmi di quei giorni del gennaio 1968. “Non ci pensi, mi dica se le piace il vino”, dicono.

O magari posso aggirarmi nella irreale Gibellina Nuova, tra case basse e bianche, strade gigantesche e un vago sentore di decadenza. E fermarmi a guardare a bocca aperta le opere di Consagra sparse un po’ dovunque tra piazze e strade. E camminare lungo il Sistema delle Piazze di Purini e Thermes cercando di capire perché mi trovo completamente solo a percorrerle. O posso alzare la testa al cielo e ammirare la gigantesca sfera bianca della Chiesa Madre progettata da Ludovico Quaroni, richiamo esplicito al contatto col Divino.
O posso perdermi nel dedalo di vie del Cretto di Alberto Burri, gigantesco e potentemente simbolico sarcofago della Gibellina vecchia. E provare a sentire se è vero quello che mi ha detto un ragazzino al quale ho chiesto indicazioni. E cioè di stare attento perché lì dentro si sentono le voci di quelli che sono morti in quel terremoto e ti chiedono di raccontare la loro storia a tutti.
Ma non chiedetemi se le ho sentite davvero, quelle voci.
La foto con il titolo, di Mario Mattia come l’altra, è Gibellina vecchia, il Cretto di Burri
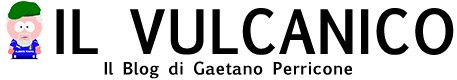
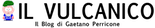







Commenti recenti