di Sergio Mangiameli
Mi svegliavo alle sei del mattino per andare a prendere l’autobus, che mi portava a scuola. A dieci chilometri, un liceo di un paese col desiderio di città, dove ci sono più chiese che tabaccai.
Mi alzavo col buio e dimenticavo sempre, la sera prima, di mettere il pile vicino al letto, così, assonnato, mi maledicevo mentre lo andavo a cercare per la casa. Mi sedevo a far colazione col sogno appena sganciato, e in parte dimenticato, e sentivo mio padre già pronto per la giornata, con un timbro nitido, come un motore in moto da un po’. Mia madre invece stentava, come me, anche a respirare in posizione eretta. Ricordo che non volevo vedere, immaginando ancora il cuscino.
Chissà Dio da piccolo, se si alzava così presto… “Diuccio, forza, sbrigati che l’autobus non aspetta te!” “Madonna, mamma, un attimo”.
Cose così, pensavo, mentre mi lavavo e mi vestivo. Ma quella che più di tutte mi faceva prudere il culo, non era tanto alzarmi alle sei, abbandonare i miei sogni sul cuscino, ascoltare l’organizzata idiozia di mio padre, o l’acuto pessimismo cosmico di mia madre – che vedeva un tuffo nell’inferno, ogni mattina –, no. Era l’intoccabile destino che mi attendeva nei successivi dieci minuti, una volta varcato il cancello di casa.
Mio padre faceva la manovra perfetta – lucido come se fosse dentro una gara! – e percorrevamo il tratto di strada fino alla fermata dell’autobus. Una strada elevata verso il giorno che stava per nascere, che poi curvava offrendo visioni naturali davvero stupende.
Sempre al solito punto, io dicevo: “Mi piace molto questo tratto”, con l’intonazione giusta perché lui lo sottolineasse con un gesto, o solo con una flessione dello sguardo. Quando non dicevo niente, era perché avevamo litigato. Io sapevo e lui non cercava l’intesa. Ma per assurdo, era l’unica abitudine a chiamata, che mi piacesse. Da qui in poi, proprio oltre quel metro di strada, il fastidio cresceva. Cresceva e, nella discesa verso la fermata, diventava nervosismo, nausea, mi si riscaldavano le orecchie e nel piazzale mi veniva voglia di urlare. Una volta pensai di prendere a ceffoni proprio lui, mio padre. Un sonorosissimo schiaffo a centro di faccia.
I pensieri più strani, quelli capaci di rompere tutto in un attimo, mi hanno sempre affascinato. Che so, nel mezzo della lezione, alzarmi e intonare con serietà un verso di Jovanotti a squarciagola, e poi tornare a sedermi; oppure, a messa, avvicinarmi all’altare e, interrompendo la funzione, comunicare al prete che sta dicendo un montagna di cazzate: “Guardi, è meglio che adesso LA SMETTA! HA CAPITOO?! ECCHECAAZZO!”, poi chiudere con un botto fragoroso il messale romano e battere forte il palmo sul marmo. Cose così.
Che è come tagliare un albero: ci vuole poco, fa un chiasso enorme e niente sarà più come prima. Vedere l’effetto che fa. Diamo un giro di vite diverso al destino, rompiamogli i coglioni.
Visto che ne stiamo parlando, ve lo dico: è soprattutto quando mi trovo in situazioni formali e precostituite, che mi scatta la molla di romperle, spezzare la linea calma e tranquilla dell’abitudine, della sicurezza assistita che mi fa salire il conato – io sento l’acido che sale, davvero. Quando mi trovo davanti al medico, lui con la cravatta, gli occhiali puliti, il camice bianco, la sua aria di seria, ordinata sapienza, ecco, lì mi scatta e vorrei fargli un grandioso, potente, lunghissimo urlo a due dita dal naso. Vorrei vedere le sue pupille dilatarsi, il vento del mio urlo sui suoi capelli dritti, il collo tendersi all’indietro.
Così. Nient’altro. Per sfizio, per dare un calcio in culo a quella scassa minchia dell’abitudine.
Ma non l’ho ancora fatto.
Dicevo, della fermata dell’autobus – torniamo lì.
Mio padre girava a sinistra e compiva un semicerchio esatto al centimetro, per posizionarsi dall’altra parte, vicino al marciapiedi opposto.
A sinistra, ferma, c’è già quell’orrenda macchinetta grigia e gli abitanti – credo che dormano lì dentro – fanno ciao con le manine. Gliele trancerei.
Ci fermiamo. Motore spento. E il film si srotola con le sue scene.
Uno, arriva un frigorifero blu capovolto con quattro ruote, l’autista ha la fregola di salutare subito, prima di fermarsi – ma gli altri no, guardano con lo scolo della vita negli occhi, di una tristezza lacerante, come deportati. Gli farei l’eutanasia.
Due, dalla strada di fronte si materializza come un miracolo, o un incubo, un ragazzo che sembra stia in piedi per una sola vite, tanto incerto è il procedere e instabile il suo assetto: secco come un fil di ferro, piegato. Ha sulla testa una cuffia esagerata che penso gli trasmetta al cervello musica muta. Deve ascoltare per forza un’assenza, per come il suo viso rimanga immobile. Gli darei due ceffoni a forbice, a braccia tese.
Tre, dietro giunge silenziosa una station-wagon metallizzata, e si mette a un metro da noi. Ma è un bluff, perché dentro c’è una madre che gesticola e parla e si sistema i capelli e non smette di parlare, di gesticolare, di cercare posizione per quel cazzo di capelli, e quel figlio zitto, seduto ordinato, sguardo basso, impassibile come un prete nel confessionale. Lei che tritura e lacera e deflagra, e lui niente. Dallo specchietto vedo due mondi opposti a contatto, dentro la stessa macchina. Lui non smette di rimanere ordinato e muto, lei di distruggere la pace. A lui, una caramella al curaro. A lei, un colpo netto con una tavola chiodata.
Poi, c’è il quattro. Il quattro è fisso, non arriva, è lì. E’ Meandro il pescivendolo, che scarica il pesce dal suo furgoncino-bianchino alla sua bottega. Pesce-fresco. Viva il cazzo. Chi è quel deficiente che va a mettere Pesce-marcio nell’insegna? Meandro conosce un solo modo di scrivere la sua insegna, come un solo modo di posteggiare il furgoncino-bianchino, e un solo modo poi di adunare la roba che diventa spazzatura. E poi si accende quella maledetta sigaretta al pesce-fresco, nel solito esatto centimetro, con il solito preciso gesto. Una bomba, per far resuscitare i pesci nella stessa maniera con cui sono morti.
Infine, ecco l’autobus. Una balena sorridente che ingoia e non divora, e ci scaricherà tutti nel porto di Sidney, come fossimo tutti davvero alla ricerca di Nemo, come se la scuola fosse chissà quale tesoro perduto. Saliamo senza salutarci, da veri professionisti adolescenti. Ma Tano, il pilota della balena, sì. Lo salutiamo. Da giusti ragazzi di strada.



Poi un giorno di autunno, dopo aver passato la sequenza mortale del solito, ritrito film, mentre ero lì seduto dentro la balena, col tempo contato ché alla successiva fermata sarebbe salito Mariso, il mio migliore amico – un tipo sveglio che parlava più rapido di un insulto –, mi sentii prudere il culo. E quando il culo prude, vuol dire che il grumo è denso abbastanza perché la definizione del suo volume stia tutta in un pugno: dovevo trovare il risultato al problema. Ora. Prima che Mariso mi sparasse nelle orecchie una raffica di parole spuntate, dovevo trovare la conclusione alla rivoluzione che avevo in mente. Adesso. Cazzo. Il gesto finale, un disegno conclusivo, qualcosa di secco e liscio, che fosse stato capace di cambiarmi la vita, di fare il giro di boa, di segnare definitivamente la svolta… Qualcosa di immediato e geniale, piccolo e sconvolgente. Una virgola, o una prospettiva.
Ma sì. Ci sono! Ci sonoo!!
“Ciao Marianno”
“Ciao Mariso. Domani la mia vita sarà totalmente, assolutamente diversa. Ho un piano”
“…”
“Quando arriverò al piazzale, dirò a mio padre di non girare subito a sinistra, ma di accostare sulla destra. E guardare il piazzale così, la macchinetta grigia, il frigo blu, il fil di ferro piegato, la confessione, Meandro, tutti da un altro taglio”.
Feci un cenno con la mano a tagliare l’aria, e inclinai la testa di qualche grado.
“Da lì, il film non sarà più lo stesso. E io sarò salvo”, lo dissi come se avessi letto la didascalia a una foto.
Mariso sgranò gli occhi e, miracolo, o incubo, le pallottole si bloccarono. Non fece nemmeno un segno di aver capito. Rimase così fino a Sidney, con le parole dentro. Anche la balena continuò la sua navigazione placida e davvero sembrò non cogliere che niente, invece, sarebbe stato più come prima.
Ma io no.
Io respirai profondamente e guardai fuori dal finestrino un panorama stupendo, liscio, morbido e mi sentii già benissimo. Poi feci una cosa che rimase nella storia di quel tratto di oceano.
Mi alzai e cominciai a cantare, a petto pieno e in perfetto inglese, la canzone di Nemo.
.
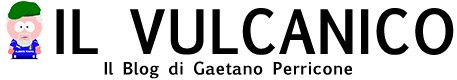
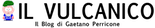

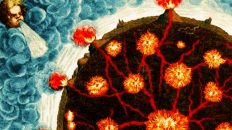





Commenti recenti